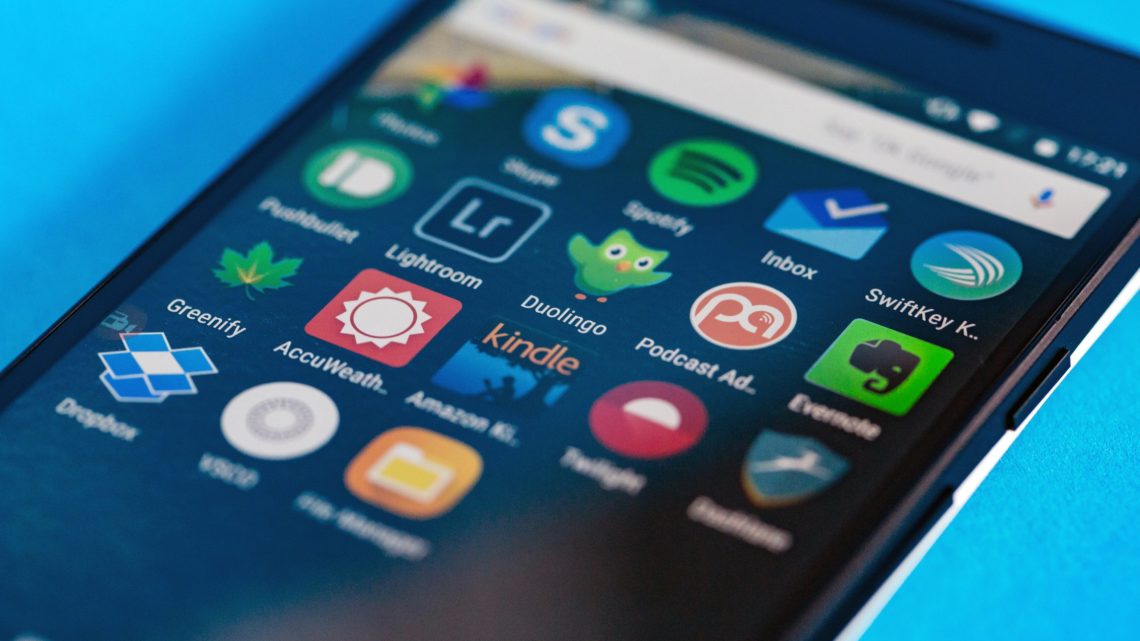Premessa (storico-sociale)
Può darsi che vi giunga nuova, ma nella vita c’è di più che starsene seduti a stabilire contatti (David Foster Wallace)
«Le reti costituiscono la nuova morfologia sociale della nostra società e la diffusione logica di rete modifica in modo sostanziale l’operare e i risultati dei processi di produzione, esperienza, potere e cultura».[2] Sono passati poco meno di due decenni da quando Manuel Castells, il profeta intellettuale della network society intravedeva nel concetto di «rete» il paradigma con il quale decifrare il (media)mondo, i comportamenti degli individui e le relative ricadute socio-culturali. La rete, infatti, ha trasformato radicalmente il nostro sensus technologicus: grazie alla tecnologia microelettronica e all’informatica nascono quelle che Longo definiva «le macchine delle mente» fatte proprio di reti e calcolatori elettronici che in poco tempo diventano «macchine del corpo-mente», ibridi (sempre secondo la visione di Longo) capaci di partorire il simbionte uomo-macchina, quell’homo technologicus[3] capace di auto-organizzarsi, auto-narrarsi e auto-rappresentarsi grazie agli innumerevoli meccanismi artificiali di sostituzione della nostra umanità. Ed ecco che dimensioni come ubiquità, virtualità, oltre il senso del luogo,[4] mediapolis,[5] technopoly,[6] megamacchina,[7] mediamorfosi,[8] nativi digitali,[9] convergenza,[10] (e molte altre ancora) prendono il sopravvento nell’universo caotico dei media studies delineando i contorni di quella che ormai definiamo comunemente «cultura digitale».
Una cultura che alcuni considerano un vero e proprio ambiente dell’esistenza, uno spazio capace di fagocitare tutto il preesistente, un contesto polisemico e di difficile comprensione nel quale esiste una «distribuzione spaziale della produzione che permette di individuare centri e periferie della comunicazione».[11] Questa dicotomia (tra centro e periferia) ha caratterizzato la storia dell’umanità. Vivere al centro di una città, ad esempio, significa(va) essere protagonisti della vita urbana, interpreti dinamici del presente ma anche esploratori del futuro. Abitare in periferia invece ha, da sempre, rimandato a un’esistenza distante, esclusa, statica. L’uomo della periferia è immobile, estraneo alle innovazioni del centro, emarginato. Con l’avvento della tecnomedialità, questa separazione concettuale si è certamente ridotta, anche se non del tutto. Se da un lato le nuove tecnologie dell’informazione si sono diffuse in tutto il globo collegandolo, dall’altro la velocità di diffusione tecnologica è stata selettiva sia sotto il profilo sociale che funzionale.
Scrive Castells: «La sequenza differenziale nell’accesso al potere della tecnologia di popoli, Paesi e aree geografiche costruisce una causa decisiva dell’ineguaglianza della nostra società. Le aree disconnesse sono discontinue in termini culturali e spaziali: si trovano nelle inner cities[12] americane o nelle banlieues francesi, nonché nelle baraccopoli dell’Africa o nelle aree rurali povere di Cina e India. Tuttavia, le funzioni, i gruppi sociali e i territori del globo dominanti sono connessi, agli albori del XXI secolo, a una nuova rete tecnologica che ha iniziato a prendere forma come tale soltanto negli anni Settanta».
Oggi, più di 40 anni dopo, il progresso ha permesso alle connessioni tecnologiche di diventare una delle priorità delle policies di governi e istituzioni. Ma non solo. Si è passati da una logica (puramente tecnica) del be connected a una prospettiva (onnicomprensiva) dell’always online. Ciò che conta non è tanto il tipo di connessione o di rete ma le modalità attraverso le quali mi connetto e costruisco esperienze di rete. Il tecnocentrismo, quindi, ha perso il suo peso specifico lasciando spazio alle capacità creative, alle relazioni, alla coscienza. In una sola parola all’uomo. Si è passati da ambienti nei quali l’uomo non è più immerso[13] ma emerge con la sua umanità, dei quali decide le sorti e i colori nel bene e nel male, nei quali proietta se stesso. Nella contemporaneità digitale quello che era il centro (la tecnica) cede il passo a ciò che era periferia (l’uomo) ristabilendo l’equilibrio originario che vede nell’individuo il nucleo generatore di ogni espressione tecnologica.
Dalle reti digitali all’umanità mediale
I media sono rimasti senza un proprio medium (Francesco Casetti).
Questo passaggio di consegne (dal tecno-centro all’uomo-centro) è la risultante di un apparente paradosso. L’avvento delle reti sociali (Facebook e gli altri «social»), la facilità di utilizzo dei diversi device (sempre accessibili a livello di costi), la diffusione esponenziale della tecnologia wifi, il moltiplicarsi di applicazioni capaci di soddisfare bisogni, invece di rafforzare la dimensione tecnologica l’ha, di fatto, sfumata, permettendo alle categorie umane di (ri)affermarsi. Questo paradosso si traduce in una condizione che Ruggero Eugeni definisce postmedialità, un processo culturale che vede i media naturalizzarsi, soggettivizzarsi, socializzarsi.[14] Si tratta di un passaggio complesso che investe non soltanto i dispositivi tecnici ma i comportamenti comunicativi, le logiche della produzione culturale, le relazioni, il consumo e, quindi, anche i processi educativi e pastorali. Comprendere il postmediale significa rendersi conto che il nostro legame con i media va al di là della concretezza tecnologica (lo strumento da utilizzare o lo spazio da abitare) ma diventa un’esperienza naturale. La vita non è né online né offline ma si dispiega interamente nella continuità tra materialità e simbolica tecnologica, secondo un’esperienza onlife[15] nella quale «comunicazione, interazione simbolica e vita quotidiana sono tenute insieme dallo stesso tessuto connettivo tecnologico digitale. Questa “interpretazione biologica” della tecnologia apre all’idea che non si tratti semplicemente di sapersi “spostare” saltuariamente all’interno di una dimensione digitale “separata”, ma di saper vivere quotidianamente in relazione sia con il fisico sia con l’elettronico; saper gestire lo spazio e il tempo quotidiano con lo spazio e il tempo digitale, che si compenetrano fra di loro. Questa situazione rappresenta una grande sfida educativa [e pastorale] perché si tratta di un’attività completamente inedita, che coinvolge tutte le generazioni: tutti sono chiamati a sviluppare una serie di competenze – una volta destinate a un ristretto gruppo di professionisti – relative alla produzione culturale mediale (elaborare l’informazione, creare contenuti, gestire la produzione simbolica)».[16]
L’individuo, dunque, si trova difronte a una importante sfida: quella di riappropriarsi di sé. Lo potrà fare anzitutto abbattendo pregiudizi e barriere culturali che per troppo tempo lo hanno subordinato al moloch tecnico, lo hanno inquadrato come nodo sterile di una rete materiale e impersonale, sacrificando inevitabilmente la sua essenza personalistica e sociale: quella di essere uomo o donna in una società. Per indicare questo processo di (ri)emersione dell’umano usiamo l’espressione umanità mediale,[17] ovvero quella condizione che, da un certo punto in poi della storia, vede l’individuo convivere e coesistere con i tecnomedia in modo libero e progettuale. L’umanità mediale ristabilisce i termini di questo legame (tra uomo e media) evidenziando come il suo equilibrio sia la risultante di decisioni prese in totale libertà, senza meccanismi (presunti) di controllo, potere e sopraffazione.
L’organizzazione dell’umanità mediale è certamente favorita dai meccanismi del digitale che con la loro infinitizza, disponibilità, facilità di accesso, diventano opportunità straordinarie per l’affermazione delle categorie dell’umano. Non siamo più soltanto spettatori di un programma televisivo, consumatori di prodotti mediali, utilizzatori di uno strumento ma diventiamo protagonisti di pratiche dalle quali prima eravamo esclusi. Da spettatori diventiamo spettAttori,[18] da consumatori diventiamo prosumer.[19] E tutto questo avviene attraverso un meccanismo che possiamo definire proiettivo; nei media digitali, infatti, possiamo proiettare (dal latino prōiectŭs, progetto) ciò che siamo: il bello (il buono, il giusto) che ci contraddistingue o il brutto (il falso, l’illecito) che può sporcare le nostre esistenze. L’umanità mediale, quindi, destruttura idee alterate e patologiche (di uomo) come simbionte, cyborg, post-umano e ci (ri)colloca lì, dove siamo sempre stati, senza alcuna forzatura. Libertà, autodeterminazione, indipendenza diventano i criteri guida di una società onlife, nella quale i formati tradizionali dell’esistenza si mescolano (senza impedimenti) alle nuove pratiche digitali. Ci guardiamo in faccia e ci relazioniamo su WhatsApp, leggiamo i giornali e ci informiamo su Twitter, guardiamo un film al cinema e una (web)serie su YouTube, compriamo nel negozio sotto casa e acquistiamo su Amazon. La congiunzione «e» evidenzia come un’azione non sia sostitutiva o oppositiva rispetto a un’altra ma sia così integrativa da costruire paradigmi sociali misti, eterogenei eppure riflessi autentici della nostra umanità. Questi formati dell’esistenza riguardano tutti indipendentemente dall’età, dalla provenienza geografica, dal reddito e dalle altre variabili sociometriche che caratterizzano gli attori sociali. Il digitale normalizza le differenze intellettuali create da decenni di determinismo tecnologico (i media come strumenti) e visioni ecologiche (i media come ambienti) e destruttura stereotipi concettuali che inquinano la realtà sociale mediata dalle tecnologie digitali. Tra questi il cliché del «nativo digitale» che altro non è che il «volto che abbiamo dato a una paura: la rapidità del progresso di questi anni e dei ritmi di vita a cui siamo sottoposti che porta il dialogo fra le generazioni, già di per sé arduo, a incepparsi di più. Il mito, una volta smitizzato, ci riporta faccia a faccia con il mostro: non ci capiamo e ci capiamo sempre meno perché andiamo velocissimo. La velocità è una delle cause della “crisi dell’esperienza”. Andiamo così veloci che non riusciamo a fare esperienza delle cose, figuriamoci trasmetterla alla generazione successiva».[20]
Conclusione: dall’umanità in rete alle «reti di umanità»
E andate con l’unica promessa che abbiamo: in mezzo al deserto, alla strada, all’avventura, ci sarà sempre la «connessione», esisterà un «caricabatterie» (Papa Francesco)
La crisi dell’esperienza si traduce spesso in comportamenti deresponsabilizzanti. È molto più semplice, ad esempio, per un adulto liberarsi dagli obblighi genitoriali attribuendo la responsabilità degli errori dei figli all’utilizzo eccessivo di uno smartphone. Nello stesso tempo (i numerosi casi di cronaca ce lo confermano) assistiamo a derive di giovani adultizzati che deformano se stessi attraverso un uso distorto del dispositivo tecnologico. L’ostentazione della propria immagine (la cosiddetta «schiavitù del selfie»), le dialettiche conflittuali fino a veri e propri atti criminosi (bullismo, gioco d’azzardo, pedopornografia, solo per citarne alcuni) evidenziano come spesso l’individuo non è ancora capace di comprendere appieno che l’online rappresenta soltanto una porzione (vera) della propria, intera esistenza. In rete, spesso tendiamo a plusumanizzarci[21](eccediamo di umanità) ossia a radicalizzare i nostri comportamenti, le nostre idee, le nostre posizioni. Oppure ci limitiamo, nascondiamo, evitiamo di “esserci” perché vittime delle nostre paure (essere spiati, derubati dell’identità, adescati). Le giovani generazioni non sono esenti da queste deviazioni anzi rappresentano la prima generazione che vive come “normale” l’esperienza tecnologica. Sarà necessario, pertanto, che genitori, insegnanti, educatori, pastori, non si sottraggano alla responsabilità educativa. Educare ai media, significa educare i media ovvero tutti quanti noi in quanto loro proiezione. Significa scoperchiare ciò che di buono ci contraddistingue ed eliminare, di conseguenza, il negativo. Significa traslare la nostra qualità etica negli spazi digitali senza essere altro da ciò che siamo. Significa, infine, essere non solo un’umanità in rete ma soprattutto reti di umanità, gruppi di persone che oltrepassano la materialità tecnica per tornare a connettersi realmente sia offline che online. La generazione che oggi nasce con i media digitali non sarà diversa da quelle passate se da loro erediterà e assimilerà le virtù e buone maniere. Allo stesso tempo toccherà agli adulti farsi carico di questo transito educativo carico di insidie ma anche di meravigliose possibilità. I giovani di oggi saranno adulti connessi non esclusivamente in senso tecnico. Saranno connessi perché potranno essere artefici di reti globali nelle quali riverberare la propria umanità fatta di bellezza e di rispetto. È questo il senso autentico della connessione, della rete e della vita in rete. Reti fatte di uomini connessi. Reti verticali (genitori/figli, insegnanti/discepoli) nelle quali il rispetto dell’autorità è imprescindibile. E reti orizzontali (i fratelli, gli amici, i compagni di studio, i colleghi di lavoro) nelle quali dovranno prevalere il confronto, la condivisione, l’aiuto reciproco, la gratuità, il dono. Concludiamo con una parola: amore. Quell’«amore per gli altri che – come ci chiede papa Francesco – non può essere riservato a momenti eccezionali, ma deve diventare la costante della nostra esistenza»,[22] online e offline.
Massimiliano Padula, docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi presso l’Istituto pastorale Redemptor Hominis della Pontificia Università Lateranense
(pubblicato su Orientamenti Pastorali n.5, EDB, Bologna 2018 – tutti i diritti riservati)
[2] M. Castells, La nascita della società in rete, Milano, Università Bocconi 2003, 11.
[3] Cf. G.O. Longo, Homo technologicus, Meltemi, Roma 2005.
[4] Cf. J. Meyrowitz, Oltre il senso del luogo. L’impatto dei media elettronici sul comportamento sociale, Baskerville, Bologna 1995.
[5] Cf. R. Silverstone Mediapolis. La responsabilità dei media nella civiltà globale, Vita e Pensiero, Milano 2008.
[6] Cf. N. Postman, Technopoly. La resa della cultura alla tecnologia, Bollati Boringhieri, Torino 1993.
[7] Cf. S. Latouche, La megamacchina. Ragione tecnoscientifica, ragione economica e mito del progresso, Bollati Boringhieri, Torino 1995.
[8] Cf. R. Fidler, Mediamorfosi. Comprendere i nuovi media, Guerini e Associati, Milano 2005.
[9] Cf. H. Jenkins, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2013.
[10] Cfr. M. Prensky, (2001) “Digital Natives, Digital Immigrants Part 1”, On the Horizon, Vol. 9, 5, pp.1-6.
[11] P. Ortoleva, Mediastoria. Mezzi di comunicazione e cambiamento sociale nel mondo contemporaneo, Net. Milano, 2002, 213.
[12] Aree centrali di una città degradate e/o in stato di abbandono.
[13] Cf. M. Padula, Immersi nei media. Il nuovo modo di essere vivi, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2009.
[14] Cf. R. Eugeni, La condizione postmediale. Media, linguaggi e narrazioni, La Scuola, Brescia 2015.
[15] Cf. L. Floridi (a cura di), The onlife manifesto. Being human in a hyperconnected era, Spriger, Berlino 2015.
[16] F. Ceretti, «Educare i media: la pedagogia di fronte alla sfida digitale. Nuove tecnologie comunicative ed educazione della persona», in I Laterani, 6, Lateran University Press, Città del Vaticano 2018 (forthcoming).
[17] Cf. F. Ceretti – M. Padula, Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive e educative, Ets, Pisa 2016.
[18] Cf. M. Padula – G. Baggio (a cura di), Dalla mondovisione all’endovisione. Pratiche e formati dello spazio televisivo, Ets, Pisa 2017.
[19] «Il prosumer è colui che riunisce in sé le azioni della produzione e del consumo. Nel web 2.0 il prodotto in parte è creato da coloro che poi lo consumeranno: in luoghi virtuali come Facebook, Wikipedia o i veri e propri blog, sono gli stessi consumatori-fruitori a produrre i contenuti». Cf. G. Ritzer – N. Jurgenson (2010), «Production, consumption, prosumption. The nature of capitalism», in The age of the digital «Prosumer», Journal of consumer culture, 10(1), 13-36.
[20] A. D’Avenia, «Il mito dei nativi digitali» in La Stampa, 18 dicembre 2013, 1, 31.
[21] F. Ceretti – M. Padula, Umanità mediale. Teoria sociale e prospettive e educative, op. cit.
[22] Papa Francesco, Regina coeli, 06 maggio 2018.