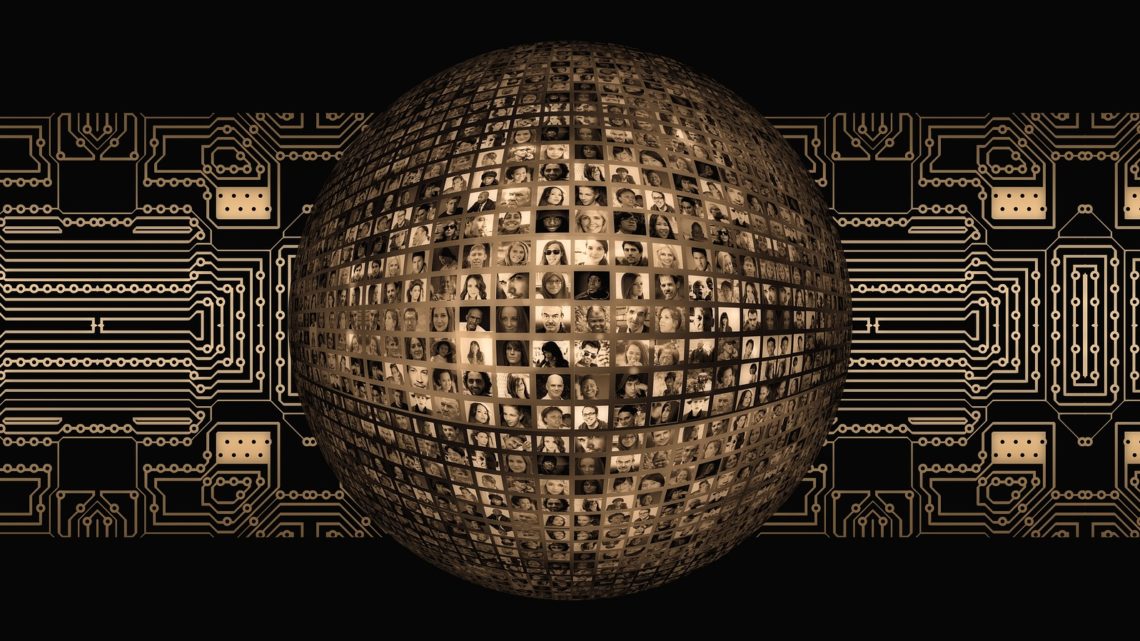Adriano Fabris – professore di filosofia morale presso l’Università di Pisa
La nostra epoca è ormai generalmente definita “l’età della comunicazione”. Ciò non significa certo sostenere che in precedenza, nelle varie fasi della storia dell’umanità, la questione del comunicare non abbia inciso in maniera decisiva sui modi in cui l’uomo veniva a rapportarsi al mondo, agli altri uomini, a se stesso. Infatti l’essere umano è stato a più riprese definito, nel corso della tradizione, proprio a partire da una tale vocazione comunicativa: una vocazione, peraltro, che consente appunto di comprendere il crescente coinvolgimento umano, nel mondo d’oggi, all’interno dei vari processi di comunicazione. Tuttavia, nella realtà contemporanea, l’incidenza di questi processi sul complesso delle relazioni fra uomo e uomo, e fra uomo e mondo, ha assunto livelli in precedenza sconosciuti. Ciò vale sia da un punto di vista quantitativo che in una prospettiva qualitativa. Non solo, infatti, siamo bersagliati, travolti da flussi di informazioni e da messaggi la cui sovrabbondanza risulta ormai inversamente proporzionale all’efficacia della loro ricezione, ma soprattutto una tale immersione in un ambiente attraversato dalle più diverse forme comunicative sembra comportare una vera e propria mutazione antropologica. In altri termini: le trasformazioni che riguardano i mezzi di comunicazione che l’uomo usa sembrano addirittura modificare, in definitiva, l’uomo stesso. Certo: una tale mutazione antropologica non va enfatizzata. Si tratta di una trasformazione che s’innesta su quella struttura comunicativa che costituisce l’essere stesso dell’uomo e che lo spinge, in un modo che richiede di essere governato, in una particolare direzione. Vi è infatti un evidente rapporto fra il modo in cui una tecnica viene usata e i comportamenti e le abitudini indotti da un tale uso. Lo si può ad esempio verificare già a proposito della storia della scrittura prima ancora che in relazione alle vicende recenti della televisione. Ecco perché i mezzi di comunicazione non possono essere considerati semplicemente come strumenti. Anche se in apparenza così sembrano presentarsi. Non si tratta infatti di meri strumenti che possono essere utilizzati per scopi particolari, non si tratta cioè di mezzi neutri, neutrali. Le cose, come abbiamo accennato, sono infatti più complesse: nella misura in cui i mezzi di comunicazione hanno una specifica incidenza su chi li usa, e addirittura prescrivono specifiche modalità del loro utilizzo, non è possibile considerarli solamente in tal modo. Essi insomma non sono solo propriamente “mezzi”, ma risultano, appunto, media: contesti di relazione in cui è possibile muoversi, ambiti all’interno dei quali compiere le proprie scelte. E, a ben vedere, questa concezione non è poi molto lontana da quella biblica, prima, e cristiana, poi: la concezione per la quale appunto la parola si configura non già, solo, come strumento di relazione, bensì, anzitutto, come relazione essa stessa, come rapporto in atto e condizione stessa di un tale rapporto.
La persona come essere comunicativo
Nuove, per molti aspetti, sono insomma le sfide che lo sviluppo delle comunicazioni comporta per l’uomo di oggi. E dunque con questa situazione inedita, in un mondo che si trasforma con velocità vertiginosa, è necessario fare i conti. Bisogna farlo evitando – per usare ben note categorie – sia di assumere posizioni “apocalittiche”, sia di proporsi entusiasticamente, nei confronti di tale realtà, come “integrati” o integrabili. Bisogna vedere se e in che modo, invece, con essa è possibile confrontarsi. Bisogna dare risposte concrete a quelle domande da cui l’uomo d’oggi, e nella fattispecie il credente, si sente interpellato nella sua vita e nella sua fede. Quali sono allora i rischi e le opportunità che questo “nuovo areopago” comporta, quali i criteri per operare, all’interno di tale contesto, con il giusto discernimento critico, e quali concrete indicazioni e strumenti per lo sviluppo di una pastorale adeguata alle nuove sfide della comunicazione? È in tal modo possibile non solamente comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, ma anche ripensare questo stesso mondo a partire dal Vangelo e dalla forza comunicativa in esso presente? Infatti, un confronto adeguato con la situazione attuale può compiersi solo avendo chiara consapevolezza di chi siamo veramente. In altre parole, per non essere preda fin troppo facile di usi distorti del comunicare, è necessario recuperare ed assumere propriamente una determinata idea di uomo. Nell’ambito della tradizione cristiana questa è l’idea dell’uomo come persona. Si tratta, ben lo sappiamo, di una concezione che risulta storicamente decisiva, ma che forse è ancora suscettibile, oggi, di approfondimenti ulteriori, proprio al fine di mettere in luce la sua essenziale portata comunicativa. Conosciamo tutti l’etimologia e la ricca storia del termine ‘persona’. Persona è la traduzione latina del greco prosōpon. Si tratta di un vocabolo che originariamente indicava la maschera dell’attore, il suo aspetto, e poi, più generalmente, viene a significare il ‘volto’: ciò che si presenta davanti ai miei occhi, ciò che si propone al mio sguardo (ōps). Nella trasposizione latina, però, l’esplicito riferimento alla visione viene meno. Persona, infatti, rende pur sempre l’idea della maschera teatrale, del ‘personaggio’. Ma lo fa con un riferimento diverso: giacché rimanda al personare, al “risuonare attraverso qualcosa”, al riecheggiare, all’emettere un suono che, come nel caso dell’attore, per essere udito deve passare attraverso le fessure della maschera. Il per-sonare della persona è dunque il far risuonare una voce, proclamando e celebrando qualcosa, al di là del semplice aspetto che può essere osservato. Qui il contesto dominante, allora, non è tanto quello del vedere e dell’essere visto – la dimensione dello spettacolo in quanto tale – bensì quello del parlare e del farsi udire: l’ambito, appunto, del linguaggio e della comunicazione. Si può quindi ripensare la ‘persona’ a partire dalla sua capacità di parola. Certo: non è una novità in filosofia il fatto che l’uomo cerchi di comprendere se stesso in relazione a questo suo specifico carattere. Lo stesso Aristotele, ben lo sappiamo, definiva l’uomo come zoon logon echon, come un “animale dotato di logos”. Anche se resta pur sempre da chiarire, in questa definizione, se l’uomo è semplicemente un animale come altri, con in più quest’aggiunta del logos; se il logos, poi, è davvero un suo “possesso” e, soprattutto, se il logos dev’essere inteso, principalmente, come logos apophantikos, cioè principalmente come un asserire che dice qualcosa su di uno stato di cose, e non piuttosto, anche, un interrogare, un dialogare, un invocare. Ebbene: proprio a tali domande il nesso evidenziato di ‘persona’ e linguaggio consente effettivamente di dare una risposta. Giacché anzitutto il riferimento alla ‘parola’, al ‘discorso’, è ciò che consente d’individuare, a seconda di modo in cui questi termini vengono intesi, una differenza radicale fra l’uomo e gli altri animali. Da questo punto di vista, poi, il linguaggio non risulta affatto un possesso, e tanto meno qualcosa che l’uomo per natura ha acquisito una volta per tutte, ma costituisce piuttosto una possibilità, una disposizione della personalità, che l’uomo stesso è chiamato di volta in volta ad attuare nella sua vita. Ma soprattutto, in terzo luogo, se vogliamo meglio comprendere tutti questi aspetti, se vogliamo mettere a fuoco davvero il concetto di ‘persona’, anche allo scopo di confrontarci con le urgenze del presente, dobbiamo prendere le distanze da ogni concezione unilaterale del linguaggio e recuperare, al di là del privilegio del modello apofantico, anche altri sensi del ‘parlare’. Che cosa significa infatti, più in generale, ‘parlare’? Che cosa caratterizza, secondo altri scenari, il linguaggio? In che cosa consiste, originariamente, il ‘comunicare’? La tradizione ebraico-cristiana – più di quella greca, che è orientata, come abbiamo visto, all’apofansi – ci offre sotto questo rispetto indicazioni essenziali. Infatti, come ben sappiamo, attraverso la parola Dio si relaziona al mondo e all’uomo, come mostra il libro della Genesi. Di più: grazie alla parola Dio istituisce questa relazione, e la mette in opera. Di più ancora: non solo, mediante la parola, Dio stabilisce la relazione con il mondo e con l’uomo, vale a dire si rivela, ma anzitutto crea, propriamente, il mondo e l’uomo. Dal canto suo l’uomo, certamente, non è in grado di creare quel mondo che Dio stesso ha già creato, e che ha proclamato “molto buono” (Gn 1, 31). Ma egli è pur sempre capace, in quanto è fatto a immagine e somiglianza del suo Creatore, di stabilire, con le sue parole, relazioni con le cose. Come mostra l’episodio in cui Adamo impone i nomi “a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo, a tutte le bestie selvatiche” (Gn 2, 19-20). Questa concezione subisce un radicale approfondimento nel contesto cristiano. Nel cristianesimo, infatti, la parola non è solamente la condizione del rapporto fra Dio e uomo: la parola, ad esempio nell’interpretazione giovannea, è Dio stesso, è il Cristo incarnato. Il che significa non solamente che la parola è qualcosa che risulta funzionale alla persona, quale modo privilegiato del suo porsi relazionale, ma che la persona stessa è quello che è nella misura in cui è parola, vale a dire relazione in atto. Su ciò Agostino, nel De Trinitate, scrive pagine di straordinaria profondità e rigore. Da queste suggestioni teologiche, che non posso qui approfondire come meriterebbero, emerge comunque una ben precisa concezione del linguaggio: quella per cui parlare significa istituire e mettere in opera relazioni. Il che significa: quella per cui il linguaggio è funzione di collegamento. Più ancora: quella per cui esso è, in quanto tale, collegamento in atto. Attenzione, però. Non si tratta di un collegamento omologante, che uniforma ed appiattisce su di un unico piano tutto ciò che viene messo in rapporto (qual è stato sperimentato talvolta nel corso della storia del pensiero). Tutt’altro. Si tratta di un legame che si attua in maniera duplice: per un verso, “superando” le differenze, creando un accordo; per altro verso, promovendo le stesse diversità, facendo in modo che, nel rapporto, ciascuno maturi e si comprenda per quello che è. In sé e rispetto ad altro: come accade ogni qual volta si ha una vera comunicazione. Che cosa s’intende allora, in questo contesto, con ‘comunicazione’, con ‘comunicazione personale’? ‘Comunicare’ – come dice la parola stessa, e come suggerisce la sua etimologia – significa appunto creare uno spazio comune di interlocuzione: uno spazio in cui si dà la possibilità a ciascun parlante di partecipare; uno spazio del quale ognuno, purché capace di parlare, può con piena legittimità aver parte; uno spazio del cui mantenimento e salvaguardia tutti gli interlocutori sono, in definitiva, responsabili. Ed è appunto movendo da questo sfondo, del pari teologico ed antropologico, che risulta possibile confrontarsi con le sollecitazioni e le istanze comunicative presenti nel mondo contemporaneo.
Etica della comunicazione
Tutto ciò, d’altronde, non è semplicemente un’elaborazione teorica. È qualcosa, invece, che risulta impegnativo per il credente. La concezione comunicativa della persona si ricollega infatti a una prospettiva etica forte, che si radica appunto nel fatto stesso che comunichiamo e nel modo in cui, propriamente, lo facciamo. A partire da qui possono essere individuati comportamenti specifici che vengono proposti per un’eventuale adozione. Dobbiamo dunque esplicitare, come ultimo passo della nostra riflessione, i caratteri di questa autentica etica della comunicazione. Ogni comunicazione contiene in sé, costitutivamente, una dimensione morale. La comunicazione, implica già da sempre la messa in gioco di una prospettiva etica per un motivo ben preciso: perché comunicare propriamente è un atto, e come atto si relaziona alla libertà dell’uomo, è soggetto a criteri e a regole, è segnato dalla responsabilità per le conseguenze che comporta. Non è possibile, quindi, lasciare che la dimensione comunicativa sia regolata unicamente da meri criteri di carattere tecnico o economico: non è lecito, ad esempio, che particolari scelte di programmazione radiotelevisiva vengano giustificate solo in quanto incrementano l’audience e permettono di fare business. Bisogna invece prendere coscienza di quello che potremmo definire il supplemento morale che contraddistingue i processi comunicativi nel loro complesso. Perché solo così il loro potere, che è rischio e ricchezza insieme, non viene ad essere unicamente sottoposto alle leggi del mercato, ma risulta in special modo soggetto ai criteri del buono, del giusto, del vero. Ma in che modo è possibile giustificare questo “supplemento morale”? E come lo possiamo far valere nella nostra vita quotidiana? Lo abbiamo visto, analizzando la valenza comunicativa dell’essere persona: il vero potere della comunicazione non è quello di persuadere e convincere gli interlocutori: è quello – come dice la parola stessa – che consente di creare e di salvaguardare uno spazio comune fra tutti coloro che partecipano o possono partecipare a un discorso. La comunicazione, in altre parole, apre lo spazio di una comunità, di una comunione, reale o possibile, fra le persone. E ciò, lo abbiamo visto, per far sì che l’uomo possa effettivamente realizzarsi come persona. Certo: questo modello comunicativo, com’è stato detto, subisce radicali trasformazioni nel “nuovo areopago” costituito dai moderni mezzi di comunicazione di massa. Si tratta di mutamenti che, sebbene abbiano sempre di più appiattito, unilateralmente, l’articolata dimensione del comunicare ad una funzione per lo più strumentale, sono in grado tuttavia d’incrementare enormemente gli spazi e il potere d’informazione, di coinvolgimento, di coesione propri, in generale, dell’atto comunicativo. Lo possiamo verificare nella nostra vita di tutti i giorni. Basti pensare alla capacità di collegamento potenzialmente universale, che offre internet e all’indicazione di comportamento – sii connesso – che è implicita negli sviluppi delle nuove tecnologie: da internet, appunto, al telefono cellulare. Basti pensare all’estendersi di quella comunità mediatica, in special modo radio-televisiva, della quale facciamo parte, più in maniera passiva che interattiva, in qualità di ascoltatori o telespettatori. Ebbene, proprio una tale dimensione comunitaria, che i processi comunicativi sono in grado di creare e di salvaguardare, va appunto resa esplicita e recuperata: come un elemento d’interesse morale, ben inteso, e non già sociologico. Proprio un tale aspetto va fatto valere contro la deriva strumentale dei mezzi di comunicazione di massa e la logica del target che li ha ormai egemonizzati. E proprio assumendo la prospettiva del comunicare come capacità di creare uno spazio comune può essere possibile fornire un’adeguata motivazione all’urgenza di governare i rischi ai quali siamo sottoposti per la costante esposizione ai media.