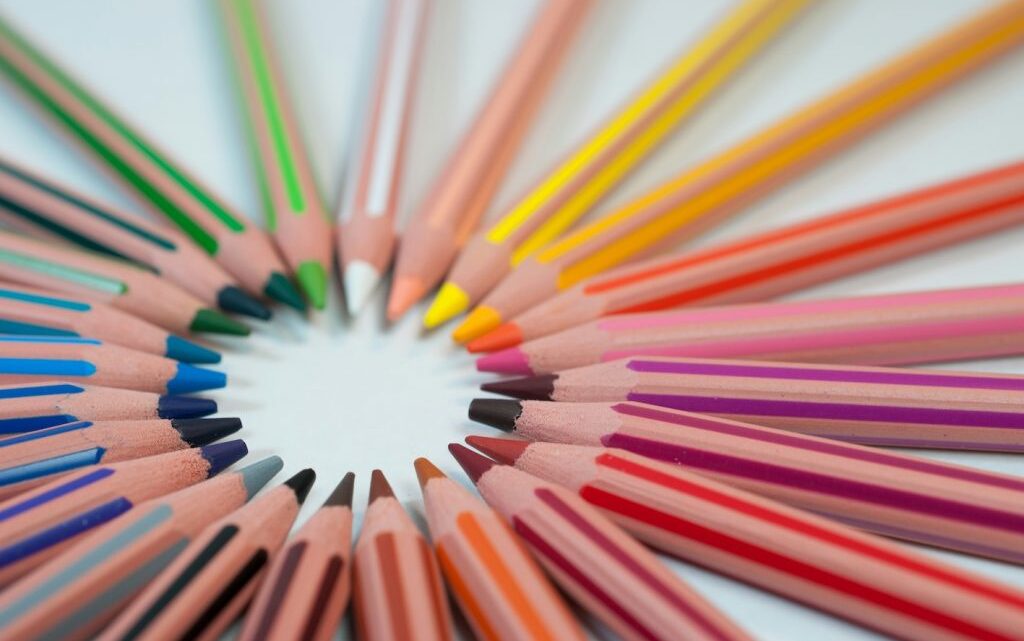Fortunato Ammendolia – informatico, studioso di pastorale digitale, intelligenza artificiale ed etica, docente invitato in istituzioni accademiche
Per una rilettura della seconda e della terza sezione dello Strumento di lavoro in una opportuna visione di pastorale digitale – per una Chiesa che si ripensa «onlife» –[2], e a esso ispirandosi, si è considerato come fil rouge quello della formazione alla sinodalità. Al n. 147 della scheda 7 viene evidenziato che: «la formazione sinodale condivisa per tutti i battezzati costituisce l’orizzonte entro cui comprendere e praticare la formazione specifica necessaria per i singoli ministeri e per le diverse forme di vita. Perché ciò avvenga è necessario che questa si attui come scambio di doni tra vocazioni diverse (comunione), nell’ottica di un servizio da svolgere (missione) e in uno stile di coinvolgimento e di educazione alla corresponsabilità differenziata (partecipazione). Questa richiesta, emersa con forza dal processo sinodale, esige non di rado un impegnativo cambio di mentalità e una rinnovata impostazione degli ambienti e dei processi formativi. Implica soprattutto la disponibilità interiore a lasciarsi arricchire dall’incontro con fratelli e sorelle nella fede, superando pregiudizi e visioni di parte. La dimensione ecumenica della formazione non può che favorire questo cambio di mentalità».
Da qui, una rassegna di buone prassi. Non si hanno pretese di esaustività e neppure di proporre esperienze che potrebbero essere intese come «di nicchia». Si tratta piuttosto di invito ad allenare l’attenzione all’altro nonché di sviluppare capacità di elaborare differenze e resistenze (culturali, di persone, di strutture, anche canoniche).[3]
Impiego dell’intelligenza collaborativa: evidenze a partire da un’originale esperienza nella chiesa di Padova
Un interessante processo di pastorale digitale educativo alla sinodalità (che ha preso forma alla vigilia della XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi[4]), lo ritroviamo nel Sinodo diocesano dei giovani tenutosi nella Chiesa di Padova dal 3 giugno 2017 al 19 maggio 2018 che, nelle sue dinamiche onlife, è passato anche attraverso una piattaforma web di approccio integrale all’intelligenza collaborativa (Collaboratorium[5]). Un evento quindi «passato» e del quale si è già dettagliatamente scritto in un precedente numero di questa rivista, ma che riprendiamo volentieri, seppure a grandi linee, per la pertinenza al tema trattato in questo contributo, e per l’unicità e profeticità che hanno caratterizzato questa esperienza. Si è trattato di un processo incoraggiato dal Servizio nazionale per la pastorale giovanile della CEI,[6] che ha dato forma in ambito ecclesiale alla prima esperienza di intelligenza collaborativa digitalmente mediata.
Una riflessione un po’ più articolata merita il concetto di intelligenza collaborativa. È evidente che ai nostri giorni, dinanzi a una questione rilevante per un’organizzazione o istituzione, nessun leader o team – capace o informato, che sia – è in grado di trovare la strada giusta da seguire, in un ambiente così complesso e accelerato. Il vero leader è il leader delle domande, colui che crea uno spazio per ottenere delle risposte. L’intelligenza collaborativa è un tipo d’intelligenza capace di confrontarsi con altri; occorrono le conoscenze, le prospettive e gli sforzi di più persone per massimizzare le possibilità di andare verso il giusto. Per dirla con il linguaggio di papa Francesco, che attraversa la Laudato si’, è quel guardare una questione nell’ottica del «tutto è in relazione», «tutto è collegato», «tutto è connesso». Ciò permette al leader di valorizzare la conoscenza e la volontà che lo circondano, pur mantenendo la decisione: «La collaborazione intelligente non si ottiene solo chiedendola, ma implementando dei processi cha la fanno accadere» (R. Mira – L. Soberòn). La piattaforma web Collaboratorium, quindi, è stata progettata per permettere a processi di intelligenza collaborativa di prendere forma a distanza.
Avendo come riferimento il documento ufficiale scaricabile dal sito della CEI,[7] possiamo evidenziare che la piattaforma dispone di dieci modelli avanzati di deliberazione a seconda della natura della questione da affrontare, per decidere, analizzare, tracciare. Più dettagliatamente, permette di: prendere una decisione specifica (sì/no); creare un «ranking» – cioè una classifica – tra opzioni; ottenere suggerimenti per l’azione; consultare apertamente su un particolare argomento; discutere di questioni/sfide complesse; assegnare le risorse tra un elenco di possibilità; prevedere le probabilità di insorgenza di varie opzioni; richiedere un «feedback and forward» su una iniziativa; avere traccia di un progetto; seguire/monitorare i risultati. In Collaboratorium è abbattuto il limite della timeline: da conversazioni ingestibili che seguono l’ordine cronologico e dove le opinioni più datate affondano, si passa a mappe di conversazioni intelligenti strutturate secondo gli obiettivi da raggiungere. Collaboratorium si attiva attraverso semplici passi: creazione della mappa delle questioni (sfide) prioritarie; scelta della squadra, cioè delle persone giuste che dovranno partecipare alla discussione; scelta del modello di deliberazione;[8] gestione delle dinamiche collaborative; estrazione, conclusione e decisione. Ciò favorisce una trasformazione culturale, ovvero la creazione di un ambiente e di una cultura di collaborazione all’interno dell’organizzazione per la co-creazione e l’impegno.
Per evidenziare l’impiego di Collaboratorium nell’esperienza del Sinodo dei giovani nella Chiesa patavina, riprendiamo alcuni passaggi della relazione tenuta, durante la LXIX settimana nazionale di aggiornamento pastorale del COP, da don Paolo Zaramella, all’epoca direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile della diocesi di Padova: «Fin dalla fase preparatoria del Sinodo si era posto il problema di attivare processi di coinvolgimento e orientamento. Occorreva fare scelte operative nei confronti di un pubblico vario e poco definito, quello dei giovani tra i 18 e i 35 anni, con un’attenzione a un’area geografica – quella della diocesi patavina – estesa su cinque province; era inoltre vivo il desiderio di far toccare con mano ai giovani che l’evento “sinodo” stava attivando dei processi di cambiamento che li vedevano protagonisti. […] Con Collaboratorium veramente avremmo avuto la possibilità di un ascolto opportunamente strutturato, che non teme distanze e non perde parole; veramente avremmo potuto tracciare il processo di sinodalità in termini di scelte. Attraverso questa piattaforma, i tanti iscritti – giovani, per la maggior parte riuniti in gruppi nelle case o nelle parrocchie – hanno potuto partecipare all’individuazione degli slogan da usare nella rete per pubblicizzare il Sinodo diocesano nei mesi a seguire. Due i passaggi. Il primo, di definizione: “Come tradurre il termine sinodo in modo che sia comprensibile a un giovane d’oggi?”; il secondo, di punteggio: “Diamo una scala di preferenze ai termini che sono emersi”. A questa prima applicazione dell’intelligenza collaborativa ne sono seguite altre […], dove i giovani coinvolti dovevano esprimere alcune opinioni sul processo del Sinodo così come lo stavano vivendo o aiutarci ad individuare delle strategie per coinvolgere i loro coetanei lontani dalla parrocchia. I giovani si sono sentiti legati in una sorta di agorà virtuale, che ha messo in collegamento molti di loro che normalmente non riescono a parlarsi e a confrontarsi proprio per le distanze geografiche; inoltre, Collaboratorium ha attivato un positivo coinvolgimento e una presa in carico di responsabilità e di processi di scelta e di decisione, vincendo quel pregiudizio molto diffuso negli ambienti ecclesiali per cui “tanto non cambia mai niente” oppure “tanto io non conto niente”. Senza dubbio, una piattaforma di intelligenza collaborativa contribuisce a superare i limiti delle riunioni in presenza – barriere spazio-temporali e dinamiche emotive –; essa permette il coinvolgimento sia di piccoli gruppi – come l’équipe ministeriale di parrocchie affidate ad un unico presbitero –, sia delle comunità stesse, in senso ampio. Dalla questione presentata e sviscerata dando tempo al ragionamento, scaturiscono, e sono tracciabili, le “opportune” scelte pastorali, che nella vita concreta saranno viste come frutto di un “cammino insieme” di prete e parrocchie, perché nulla di quanto detto è andato perduto, tutto è stato considerato. In quelle scelte le parrocchie si “riconosceranno”. Per poi tornare sulla piattaforma per una verifica, che sarà oggetto di un nuovo processo di intelligenza collaborativa. Il guadagno in termini di contributo e responsabilità laicale non sarà minimo».[9]
Ai fini della fase profetica del Sinodo delle chiese in Italia, può essere di utilità un’ulteriore osservazione. Se l’intelligenza collaborativa riletta in chiave pastorale rimanda alla sinodalità, una piattaforma come Collaboratorium apre alla necessità di piattaforme ben strutturate per una Chiesa che si ripensa «onlife», per coinvolgere, formare, condividere – anche in termini di restituzione di scelte – in un camminare insieme realmente capace di inclusione. Ciò va nella direzione delle tecnologie di comunità, ovvero della capacità della tecnologia di (ri)costruire la comunità,[10] ovvero riarticolando il rapporto tra il dentro e il fuori, in termini trasmissivi, aggregativi, partecipativi (anche di ricaduta su persone di fatto tagliate fuori dalla sfera di comunicazione intenzionale). In tal senso, si parla dei media digitali e sociali come spreadable media, ovvero come media capaci di andare oltre sé stessi, diffondersi in più direzioni ed essere generativi di relazioni.[11]
Dare voce a documenti con l’intelligenza artificiale: un caso di studio sulla codificazione canonica orientale
«Ci si potrebbe orientare verso una collaborazione tra intelligenza umana e artificiale, piuttosto che verso una sostituzione. Gli storici potranno delegare all’IA i compiti più meccanici come trascrizione, traduzione e analisi preliminare dei documenti, concentrandosi sulla parte più creativa e interpretativa del lavoro. […] Il punto non è se l’IA sostituirà gli storici, ma come gli storici useranno l’IA per fare scoperte che altrimenti sarebbero impossibili» (Benjamin Breen).[12] Questo pensiero intercetta le intenzioni alla base di un caso di studio maturato nella Pontificia Università Urbaniana, nel corso di «intelligenza artificiale, robotica cognitiva ed etica»[13], sull’idea e sulle ricerche della dottoressa Daniela D’Andrea, studiosa di diritto canonico orientale.
Il lavoro della ricercatrice si è svolto sui 16 volumi della Codificazione canonica orientale, contenenti le 22 plenarie (1935-1948[14]) della cosiddetta prima codificazione, che ha originato il Codex iuris canonici orientalis – CICO. Materiale notevole e singolarissimo, sia per lo storico del diritto che per il canonista, e, più generalmente, per ogni intellettuale; un corpora prezioso, che però mancava di un indice generale per un’agile consultazione, sia in termini di contenuto che di analisi – si pensi, ad esempio, all’esigenza di seguire l’evoluzione dei lavori e di discussioni tematiche nel corso di una plenaria e, più in generale, nell’opera –. Per sanare tale mancanza, ci si è interrogati su come l’IA potesse essere collaborativa nella stesura di questo indice, tenendo però presente che il diritto canonico, sia orientale che latino, dovesse lavorare in tandem con tutte le altre discipline, tra di esse le scienze dell’informazione.[15] L’indagine sulle possibilità applicative dell’intelligenza artificiale per estrarre informazioni dalla mole di questi volumi è andata ben oltre, focalizzandosi sulla questione della sinodalità. Infatti, l’intera codificazione è stata frutto di un processo che ha coinvolto la totalità delle chiese orientali cattoliche,[16] compresa quella latina, secondo un approccio che «sinodale», poiché proteso al pensare insieme, all’esprimersi in piena libertà per giungere al bene delle chiese orientali cattoliche[17] sempre salvaguardando il primato di Roma. Riportiamo uno stralcio del verbale della I plenaria: «Bisogna […] compiere una codificazione che sia adatta agli orientali, che faccia del bene alle chiese orientali, che risollevi la Chiesa di Oriente a quella grandezza che ha avuto nei primi dieci secoli della Chiesa. Bisogna costruire l’edificio veramente orientale, come l’ha voluto e vuole Vostra Santità così sollecito per il bene spirituale dell’Oriente»[18]. Il tutto nella raccomandazione di «evitare nella sostanza e nella forma tutto ciò che può urtare o ferire gli orientali, ma essere precisi e franchi per ciò che riguarda l’unità della Chiesa e il primato del Romano Pontefice»[19]. Circa la forma è specificato che «essa deve essere orientale e si debbono desumere, per quanto è possibile, testi dalle fonti orientali»[20]. Dallo studio della D’Andrea scaturiscono una seria di domande aperte, che esigono di dare «in pasto» a un’IA collaborativa (opportunamente addestrata) quella mole di volumi: 1) il processo che ha portato alla prima codificazione canonica – un processo che ha ricercato una convergenza tra identità e comunione – cos’ha dire alla sinodalità di oggi? Come si sono attivate le categorie dell’ascolto e del discernimento? Quali sono stati conflitti e quali risoluzioni?[21] Quale approccio per la decisione?
Riportiamo un frammento di quanto ha costituito il passo implementativo del caso di studio, ovvero «esperire modalità di passaggio dall’idea alla fattibilità». Ci soffermiamo in particolare sulla domanda fatta a Perplexity AI[22] di effettuare una ricerca su elementi di sinodalità estraibili dal processo della prima codificazione canonica orientale. L’IA, senza ulteriori indizi, ha ricavato da documenti presenti in rete – in particolare, dai numeri della rivista Nuntia[23] consultabili nel sito del Dicastero per i testi legislativi – un’ampia risposta, di cui riportiamo alcuni significati passaggi. Citando il numero 29 di Nuntia, il motore di ricerca dichiara che: «Pio XI, nell’udienza dell’8 febbraio 1937 relativa alla IV plenaria, decise esplicitamente che si adottasse per il “Codex Iuris Canonici Orientalis” l’ordine che “è in piena armonia con le tradizioni e con i desideri orientali, e quindi la divisione in titoli”. Questa decisione rappresenta un importante riconoscimento delle tradizioni orientali e delle loro specificità, dimostrando un’apertura al principio di “diversità nell’unità” che è alla base della concezione sinodale. Similmente, nelle decisioni successive riguardanti la struttura del codice, si riscontra questo stesso rispetto per l’identità orientale. Durante la XXI plenaria, “Pio XII, nell’udienza del 31 ottobre 1941, approvando le decisioni della XXI Plenaria, accettò un Indice del “Codex Iuris Canonici Orientalis” diviso in 24 titoli. Il fatto che queste decisioni venissero prese “approvando le decisioni” delle plenarie, suggerisce un processo decisionale collaborativo piuttosto che puramente impositivo».
Si è trattato di un lavoro soddisfacente, anche se la risposta sarebbe stata migliore se Perplexity avesse potuto effettuare la ricerca entro i testi di tutte le plenarie. Di fatto, inerentemente alla questione della divisione in titoli, avrebbe potuto citare le pagine del verbale della IV plenaria che ne trattano[24]. In tal modo avrebbe potuto offrire il polso della discussione e della libertà in cui si è svolta.
Conclusione
A mo’ di conclusione, si consegna al lettore un pensiero di raccordo tra quanto fin qui proposto e i contenuti del seguito dell’articolo. «È ormai chiaro che l’ambiente digitale non è un mondo parallelo o puramente virtuale, ma è parte della realtà di molte persone […]. Web e social […] costituiscono […] una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, oltre che di accesso all’informazione e alla conoscenza. […] Rappresentano un luogo irrinunciabile per raggiungere e coinvolgere […], anche in iniziative e attività pastorali»[25]
Tratto da Orientamenti Pastorali n. 3(2025). EDB. Tutti i diritti riservati.
[1] «Prossimità e accompagnamento nella comunità sinodale», in Orientamenti Pastorali, 1-2(2025), pp. 7-64.
[2] Cf. F. Ammendolia – R. Petricca, Chiesa e pastorale digitale. In uscita verso una società 5.0, Il Pozzo di Giacobbe, 2023, cap. 2.
[3] Cf. CEI, Strumento di lavoro per la fase profetica, pag. 45.
[4] Sinodo dei vescovi su «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale» (3-28 ottobre 2018).
[5] Piattaforma realizzata in Spagna dalla società DontKnow.
[6] http://bit.ly/4bCA9HS (ultima consultazione: 9 marzo 2025).
[7] https://bit.ly/4kV9uds (ultima consultazione: 9 marzo 2025).
[8] Un modello di deliberazione per ogni caso da affrontare e deliberare. Questi modelli raccolgono il 95% delle casistiche riguardanti le deliberazioni.
[9] Centro di orientamento pastorale, «Parrocchia senza preti. Dalla crisi delle vocazioni alla rinnovata ministerialità laicale – Atti della 69a Settimana nazionale di aggiornamento pastorale», in Orientamenti Pastorali 11(2019), EDB, Bologna 2019, pp. 121-124.
[10] Cf. P.C. Rivoltella, Quale presenza ecclesiale nell’attuale contesto comunicativo, Atti della 71a Assemblea generale della Conferenza episcopale italiana, Roma, 21-24 maggio 2018.
[11] Per approfondimenti, L. Bocacin (a cura di), Generare relazioni di comunità nell’era digitale. La sfida delle parrocchie italiane prima e dopo la pandemia, Scholé, Brescia 2022. Il volume testimonia gli esiti di un’importante ricerca realizzata da un gruppo interdisciplinare dell’Università Cattolica, a cui hanno partecipato anche i ricercatori del CREMIT apportando riflessioni sulle tecnologie digitali e sul rapporto tra digitale e azione pastorale.
[12] https://bit.ly/3XZG1oV (ultima consultazione: 9 marzo 2025)
[13] Corso svolto dal professor Riccardo Petricca, nell’anno accademico 2023/2024, con codocenza dell’autore di questo contributo, il quale ha seguito il caso di studio oggetto di questo approfondimento, dandogli un orientamento secondo i concetti che caratterizzano il cambiamento d’epoca in corso, per una Chiesa che si ripensa onlife.
[14] Cf. I. Žužek, Appunti sulla storia della codificazione canonica orientale, Kanonika 13, 2007, p. 50, nota 10.
[15] Cf. F. Wilfred, «Teologia e diritto canonico», in Concilium, 52(2016)5, p. 61.
[16] Il tenore del coinvolgimento orientale da parte di Roma si legge nella prima circolare della S.C. Orientale (Prot. 428/28) del 5 gennaio 1929: «[…] Sono pure invitati gli ecc.mi e rev.mi signori patriarchi e i rev.mi arcivescovi metropolitani orientali a voler indicare alla s. Congregazione pro ecclesia orientali quali persone, tra i loro prelati, sacerdoti o religiosi, credano più adatte per loro coltura, scienza e prudenza, a collaborare in questa opera, sia venendo, se del caso, a Roma, che rimanendo nelle proprie sedi, o nei propri uffici […]» in s. Congregazione orientale, Codificazione canonica orientale, prot. n. 125/31, Verbale della i plenaria, 11.
[17] «… per tutti gli studi della codificazione si vuole che siano eseguiti con la massima e piena libertà. […] come fu scritto ai patriarchi, metropoliti e vescovi fin dal 5 gennaio 1929, così si vuole attuare; tenere presenti le proprie leggi, sinodi, tradizioni, necessità, opportunità, consuetudini, privilegi e lingua ed esporre e proporre ciò che meglio si crede e nel modo che si preferisce. di proposito si vuole esclusa anche l’ombra di influenza latina, in opera che deve essere tutta a vantaggio degli orientali. quindi ancora, neppure si deve avere innanzi alla mente l’idea di preparare un unico codice per tutta la Chiesa, non potendosi ora conoscere quel che risulterà da tali studi […]», in s. Congregazione orientale, Codificazione canonica orientale, prot. n. 125/31, Verbale della i plenaria, 9.
[18] s. Congregazione orientale, Codificazione canonica orientale, prot. n. 125/31, Verbale della i plenaria, p.14.
[19] Ibidem
[20] Ibidem
[21] Si pensi all’idea, che già aleggiava alla vigilia del Vaticano I, di avere un unico codice. Alla base di tale visione era chiara la riduzione della differenza tra la chiesa latina e le chiese orientali solo a quella liturgico-rituale. Pur avendo avuto un iniziale accoglimento anche presso il papa e alcuni cardinali, è poi stata definitivamente scartata: «Il compianto card. Gasparri voleva che si facesse un sol codice per tutta la Chiesa, […] Se il C.I.C. non fosse stato già pubblicato si sarebbe potuto fare un solo codice per tuta la Chiesa con l’aggiunta forse, di non più di 150 canoni fondamentali propri alle chiese orientali, lasciando il resto ai sinodi particolari. Sua santità dapprima accettò transitoriamente con modifiche, ma alla fine escluse più volte l’idea di un sol codice, […] Osserva che è bella l’idea di un sol codice, per ragione dell’unità: a essa in caso si potrà anche giungere, ma non è da cominciare» [per cui fu solennemente stabilito che] «neppure si deve avere innanzi alla mente l’idea di preparare un unico codice per tutta la Chiesa», s. Congregazione orientale, Codificazione canonica orientale, Prot. N. 125/31, verbale della I plenaria, p. 8.
[22] Motore di ricerca basato su chat bot con intelligenza artificiale generativa che risponde alle query utilizzando testo predittivo in linguaggio naturale. Si concentra sulla ricerca e sulla fornitura di informazioni dettagliate (accurate e fattuali) con citazioni dirette. https://www.perplexity.ai/ (ultima consultazione: 9 marzo 2025).
[23] Periodico nato nel 1973, preposto a raccogliere e pubblicare atti scelti della Pontificia commissione per la revisione del codice di diritto canonico orientale (istituita nel 1972 in sostituzione della precedente Pontifica commissione per la redazione del codice di diritto canonico nata nel 1935). Ultimo numero pubblicato è il 31, con la promulgazione del Codex canonum ecclesiarum orientalium nel 1990. https://bit.ly/4ifM3Kg (ultima consultazione: 9 marzo 2025).
[24] S. Congregazione orientale, Codificazione canonica orientale, Prot. N. 452/33, verbale della IV plenaria, criteri per la redazione del C.I.C.O., «Si adotti quell’ordine che è in piena conformità con le tradizioni e con i desideri orientali e la divisione in titoli […] e la chiarisce con alcune spiegazioni», p.9, «L’E.mo Boetto: in titoli […]; l’E.mo Tisserant: In titoli […]», p. 10; N. 452/33, verbale della IV plenaria, criteri per la redazione del C.I.C.O., decisioni approvate, «Quale ordine deve seguire il codice orientale nelle sue principali divisioni: quello del C.I.C. oppure altro, conforme alla tradizione orientale? R. – Si adotti nei due testi l’ordine che è in piena conformità con le tradizioni e con i desideri orientali, e quindi la divisione in titoli», p. 2; Idem in N. 452/33, norme per la redazione del C.I.C.O. in latino, p. 1.
[25] XV Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi, I giovani, la fede e il discernimento vocazionale, Documento finale, n. 21, 22.